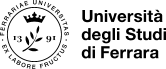Nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2013 un uomo calvo con la barba bianca rientra verso la sua casa al centro di Gioia Tauro. In paese lo conoscono tutti. È il barone Livio Musco, 74 anni, nato a Napoli, primo figlio del generale Ettore Musco, capo dei servizi segreti militari (Sifar) dal 1952 al 1955. Sua nonna era la duchessa Serra di Cardinale. Livio è l’erede di una famiglia di feudatari borbonici che ha avuto in mano migliaia di ettari di latifondo in Calabria, dal Tirreno allo Jonio. I Musco-Serra di Cardinale hanno posseduto, lottizzato e venduto le terre sulle quali sorge Gioia Tauro, principale cittadina della Piana. Hanno raccolto e venduto le olive e l’olio che nell’Ottocento andava ad illuminare le strade delle città europee. In età moderna, hanno ceduto i terreni sui quali è sorto il porto di Gioia Tauro, l’autostrada Salerno-Reggio Calabria o il fondo vicino allo svincolo dell’A3 dove è stato realizzato il centro commerciale Annunziata, un mall gigantesco dove i 19400 abitanti di Gioia Tauro potrebbero entrare tutti standoci larghi ma dove, in effetti, il traffico è raro.
Il pomeriggio di sabato 23 marzo il barone è ripreso di passaggio dalle telecamere di piazza Matteotti, centro di gravità che nel raggio di cento metri include il Municipio, la stazione dei carabinieri, la farmacia e il palazzotto dei Musco, all’inizio della discesa di via Valleamena. Lì la telecamera non arriva. Eppure il 17 novembre 2012, un altro sabato, davanti a casa dei Musco è esplosa una potente bomba carta che ha distrutto i vetri della Punto del barone e del palazzo al pian terreno. Sull’altro marciapiede c’è l’abitazione del capitano dei carabinieri, Francesco Cinnirella, che vive in affitto proprio in un appartamento di Livio Musco.
In un paese dove le telecamere hanno consentito la soluzione di tre omicidi in pochi mesi, nessuno pensa di rafforzare la sorveglianza in via Valleamena. Dopo l’attentato di novembre, del resto, il barone è il primo a tranquillizzare tutti. «Non ho nemici», dichiara. «Si è trattato certamente di uno sbaglio di persona».
È la dichiarazione di circostanza che le vittime del racket spesso presentano in segno di accettazione della legge d’omertà. E Livio Musco sa benissimo che al centro di Gioia Tauro una bomba si mette soltanto con l’autorizzazione dei veri padroni della città, la famiglia Piromalli. Teste calde e iniziative private a Gioia hanno vita breve.
Forse il barone è davvero convinto di non avere nemici. O forse, più semplicemente, se ne fotte. Livio Musco non è mai stato famoso per la sua prudenza. Da ragazzo, ha stabilito il record di notti di punizione in cella all’Accademia militare della Nunziatella. Da adulto si è messo in cento affari, con generosità e senza criterio, falsificando la firma del generale Ettore su assegni per 800 milioni di lire nel 1968 (equivalenti a circa 8 milioni di euro di oggi). Lo hanno condannato in via definitiva a cinque anni, sbattuto in cella a Vibo Valentia con il fior fiore della delinquenza locale ma alla nipote che lo andava a trovare faceva il baciamano.
Oltre a tutto questo, Livio Musco aveva un difetto letale. Parlava, parlava, parlava. A Gioia Tauro, dove mezza frase è già di troppo, lui si sentiva al di sopra della legge del silenzio. Quel paese non sarebbe esistito senza la sua famiglia, i suoi ulivi, le sue vigne e la centrale elettrica costruita dal nonno Adolfo in fondo a via Valleamena durante il fascismo.
Perciò anche il pomeriggio del 23 marzo, come al solito, Livio Musco lascia il portone di casa aperto.
Quel sabato nel passeggio primaverile fra via Valleamena, piazza Matteotti e via Roma c’è qualcosa di diverso. In città il sindaco Renato Bellofiore, ex Udc passato al Pd ed eletto dopo il commissariamento del Comune per mafia (aprile 2008), ha proclamato il lutto. Quando Musco torna a casa, si sono appena conclusi i funerali di Fabrizio Pioli, elettrauto gioiese che si è innamorato della donna sbagliata. Un amore non previsto dalle regole locali perché la donna, Simona Napoli, era sposata ed era figlia di uno ’ndranghetista. Il padre della donna uccide Pioli nel febbraio del 2012. Il corpo viene ritrovato un anno dopo, sotto due metri di terra.
Il 23 marzo alle ore 16 migliaia di persone partecipano al corteo funebre e poi alle esequie nella chiesa di San Francesco, vicino alla statale 18, in periferia. Le strade del centro sono chiuse al traffico per il lutto.
Alle ore 19 il barone Musco ha un appuntamento con il fratello Giuseppe, detto Pino, 67 anni, l’altro dei sei figli del generale Musco che è rimasto in Calabria a fare l’agricoltore. Pino aspetta il fratello maggiore per andare all’hotel 501 di Vibo Valentia dove gli ex allievi della Nunziatella hanno fissato un cena sociale.
Intorno alle 19.30, Livio non si è ancora fatto vedere. Eppure ama la puntualità. Così Pino Musco decide di entrare nel palazzo di famiglia. Trova il fratello seduto, come addormentato. Poi vede un filo di sangue dalla narice. Livio è ancora vivo, ma per poco. Morirà sull’ambulanza che, nel caos delle strade bloccate per il lutto, ci mette venti minuti ad arrivare.
I carabinieri, che devono fare pochi passi dalla stazione di via Vittorio Emanuele, sono già sulla scena del delitto. I cronisti locali ricordano l’aria di estremo nervosismo degli investigatori: il barone è stato ammazzato quasi sotto i loro occhi. Ma i cronisti riferiscono anche due particolari che segnano la sorte mediatica del caso Musco.
Primo: il barone è stato ucciso con due soli colpi, al collo e allo zigomo, sparati da una 6,35, una pistola di piccolo calibro. Qui sulla Piana, dove sparare è una cosa seria, da uomini, la 6,35 è l’arma dei “fissa”, dei fessi e delle donne, anche se il killer ha mostrato di avere una mira ad alta precisione.
Secondo: nell’arco di poche ore dopo il delitto e nella capitale storica della ’ndrangheta, si scarta l’ipotesi di un omicidio mafioso perché, appunto, i sicari delle ’ndrine non userebbero una 6,35. D’altronde, il barone passava gran parte delle giornate da solo in mezzo agli ulivi appartenuti al generale Ettore. C’era tempo e modo di sparargli due botte di lupara lontano da orecchie indiscrete.
Non che in pieno centro a Gioia Tauro, in un’affollata sera di sabato, qualcuno abbia sentito niente. Ma la lupara in campagna fa troppo “Giorno della civetta”, lo sbarco di inviati e telecamere è garantito.
Invece, con Musco morto da poco, si derubrica il movente del delitto. Il silenziatore mediatico funziona alla perfezione: pochi articoli nella cronaca locale, per due o tre giorni. Nemmeno una riga sulla stampa nazionale.
La delinquenza calabrese ha prosperato sui silenzi stampa. Ma il caso Musco è clamoroso. L’ucciso è un possidente terriero napoletano, discendente di una famiglia nobiliare e figlio del predecessore al Sifar del generale Giovanni De Lorenzo. Livio Musco è stato un bersaglio delle lotte sindacali contro gli agrari degli anni Settanta con tanto di slogan di piazza dedicato («Musco e Diana fuori dalla Piana!»). Ha sostenuto i moti dei Boia chi molla per Reggio capoluogo con l’altro napoletano sceso in Calabria Amedeo Matacena e l’altro barone don Fefè Zerbi. Eppure, niente. Soltanto chiacchiere di paese. E nei paesi del Sud l’elaborazione dei moventi è tutta un’arte.
A partire dai dati ufficiali, cioè il calibro della pistola, la radice non mafiosa del delitto, il probabilissimo rapporto di conoscenza fra l’assassino e la vittima che l’ha accolto senza timore, la vox populi elabora tre ipotesi classiche: femmine, usura, controversie familiari.
La pista femminile è rafforzata dal calibro dell’arma e, forse, dalla stessa prossimità temporale con il caso di Fabrizio Pioli, ucciso sì da un mafioso ma per questioni d’onore. Il barone Musco, alla faccia dei suoi 74 anni, era un satiro che ha finito per insultare chi non doveva. Elementi a sostegno, nessuno.
Anche l’usura è un classico per infamare la vittima e fornire attenuanti all’assassino. Eppure, Musco era in forte difficoltà economica. A parte l’immobile affittato al capitano dei carabinieri, il secondogenito del generale Ettore non aveva, di fatto, più una vite, né un ulivo.
Le sue proprietà risultano pignorate per centinaia di migliaia di euro e il barone, che viveva in modo semplice, doveva rivolgersi ad amici per piccoli prestiti. Il suo accesso al credito bancario era compromesso anche dalla condanna penale in giudicato per un cumulo di pena comprendente protesti, assegni scoperti, truffe all’Inps e alla Comunità Europea con assunzioni fasulle di braccianti.
Per questa sentenza, confermata dalla Corte d’appello di Venezia nel 2002, il barone aveva anche subìto una pena accessoria di dieci anni di inibizione dall’esercizio di attività commerciali.
Più che usuraio, avrebbe potuto essere stato lui in mano agli usurai. Ma gli strozzini non avrebbero avuto molto da spremergli.
La terza pista è quella dell’eredità, la più interessante. I beni della famiglia Musco includono, oltre ai latifondi calabresi di Gioia Tauro, Rizziconi, Placanica e Caulonia, una villa a Cava de’ Tirreni (Salerno) e la casa del generale Ettore, 500 metri quadri ai Parioli. È una doppia eredità, in effetti. La prima riguarda la successione del fratello del generale, Mario Domenico Musco detto Mimì, che non ha avuto figli e alla sua morte (1977) ha lasciato i beni in parti uguali ai sei nipoti (in ordine di anzianità, Edoardo, Livio, Ruggiero, Maria Elisabetta, Giuseppe e Maria Ida).
Questa prima eredità è stata divisa. Parte dei terreni di don Mimì è stata acquistata da Ruggiero Musco, il fratello avvocato che è anche la figura forte degli affari di famiglia. Politicamente più a destra di Livio, Ruggiero è stato presidente della Gioiese calcio all’inizio degli anni Ottanta, quando il presidente onorario del club allenato dal professore Franco Scoglio era Gioacchino Piromalli, nipote del capoclan Giuseppe, detto Peppino “mussu stortu”.
Anche il centro commerciale Annunziata, realizzato da un ambulante di San Giuseppe Vesuviano colto da improvviso benessere finanziario, è stato costruito sui terreni di don Mimì Musco. Tre mesi dopo la cessione (1998), il Comune approvò la variazione d’uso con grande beneficio per l’acquirente.
La mediazione fu fatta dall’avvocato Pino Macino che oggi è il legale di Ruggiero Musco e di altri familiari nella vicenda dell’omicidio del 23 marzo. Macino, ex vicesegretario del Pci locale, ha seguito anche la vicenda della seconda eredità, quella del generale, rimasta indivisa a causa di una lite fra i figli in sede civile e penale.
«Sull’eredità di Ettore Musco», dice Macino, «sono subito sorti problemi interpersonali fra gli eredi. I beni, circa 200 ettari, sono bloccati sotto custodia giudiziaria da oltre vent’anni e per questo Livio aveva qualche difficoltà economica. Sul suo omicidio c’è grande lentezza nelle indagini. Basti dire che la casa del delitto è sotto sigilli e chiusa da sei mesi. Nessuno ci ha più messo piede dentro».
I beni del generale sono formalmente custoditi da un noto commercialista di Reggio Calabria, Alberto Porcelli, animatore del Rotary locale e fratello di uno dei principali sostenitori politici del governatore Giuseppe Scopelliti, Aldo Porcelli della lista Reggio Futura. In pratica, però, i terreni vengono amministrati da Pino Musco, il fratello che ha trovato Livio agonizzante. Anche Pino ha una storia movimentata alle spalle. Il quinto figlio del generale ha passato un anno in carcere a Palmi con l’accusa, poi sfumata, di traffico internazionale di stupefacenti. Che sia un consumatore abituale di cocaina, a Gioia Tauro, è il segreto di Pulcinella. Nessuno in paese si è quindi meravigliato del suo arresto sabato 20 aprile 2013, quattro settimane esatte dopo l’assassinio del fratello. La polizia gli ha trovato in macchina 1,2 grammi di coca, l’equivalente della dose quotidiana, e gli ha fatto passare un fine settimana in carcere con l’accusa di spaccio.
Inoltre, gli investigatori stanno cercando una pistola appartenuta al generale. La pistola, presa in consegna da Ruggiero Musco dopo la morte del padre, sarebbe stata trovata in possesso del fratello Pino. E c’è una novità clamorosa. L’arma che i carabinieri stanno cercando è una Beretta 7,65. Non un’arma da donna.
Giandomenico Musco, 25 anni, il quinto e ultimo figlio di Livio, conferma il cambio di calibro e respinge duramente l’idea di un coinvolgimento di qualcuno della famiglia. «Non è vero, come si è scritto e come gli stessi carabinieri mi hanno detto durante i miei due interrogatori, che mio padre sia stato colpito con una 6,35. L’arma del delitto è una 7,65. Quindi niente storie di donne. In quanto alla faida familiare, non avrebbe senso risolvere a colpi di pistola una questione ereditaria. Se è già intricata, si complica di più. La mia idea su chi possa essere stato me la tengo per me, perché io devo vivere qui. Ma bisogna vedere il contorno. Questa è la Calabria. È Gioia Tauro, non la Svizzera».
Sulle tradizioni poco elvetiche della zona non c’è molto da aggiungere alle decine di volumi e centinaia di indagini giudiziarie che hanno individuato nella capitale della Piana la madre patria della ’ndrangheta moderna, quella nata dai latifondi e la più simile a Cosa nostra anche per la grande cura dedicata ai rapporti con chi governa. Gioia Tauro significa Piromalli, uno dei clan più antichi e allo stesso tempo più capaci di stare al passo con i tempi, a costo di sacrificare al loro potere assoluto alleati storici come i Molè, il loro braccio armato. Qui non affonda foglia senza il consenso dei Piromalli e chi si allarga paga di persona, come Rocco Molè che voleva diventare re del porto ed è stato ucciso nel febbraio 2008.
I Piromalli significano politica. Sono loro che accolgono Giulio Andreotti per inaugurare il porto, come racconta l’ex presidente della Commissione antimafia Francesco Forgione. Sono loro che abbattono il sindaco Vincenzo Gentile nel maggio del 1987. Lo stesso ex sindaco Udc Giorgio Dal Torrione, che ha provocato il commissariamento del Comune nell’aprile 2008, è stato arrestato e poi assolto proprio per concorso esterno in associazione mafiosa con i Piromalli nel processo “Cent’anni di storia”. A lui, come regalo per l’assoluzione, nell’aprile del 2012 hanno bruciato la macchina davanti alla stazione dei carabinieri, una palazzina gialla di proprietà della moglie di Dal Torrione. Niente telecamere, nessuno ha visto, non si sa chi è stato.
I Piromalli significano imprenditoria. Decidono chi raccoglie le olive, chi non le raccoglie, a chi si vendono e a che prezzo, come hanno sempre fatto con i Musco e con tutti gli altri proprietari, finché loro stessi hanno rimpiazzato la vecchia aristocrazia e sono diventati i maggiori possidenti.
Sulla Piana i terreni dei feudatari scesi da Napoli sono sempre stati sottoposti a guardiania da parte del clan dominante. Il custode storico dei latifondi Musco è stato Domenico Stillitano, nipote di Peppino “mussu stortu” Piromalli. Mico Stillitano è stato accusato di avere ucciso nel 1987 Vincenzo Gentile, l’ex sindaco di Gioia Tauro che era anche il medico di famiglia dei Piromalli. Condannato in primo grado, assolto in appello. E il rivale storico della famiglia Stillitano, Domenico Maisano detto la Belva di Drosi, è quello che ferì gravemente a fucilate il barone Mimì Musco dopo avergli chiesto il pizzo. Poco dopo, Maisano fu eliminato dai Piromalli.
Da tempo i padroni della Piana non limitano gli investimenti al territorio di Gioia. La casa romana del generale Musco in via Giosuè Borsi ai Parioli è stata trattata dall’agenzia Ital Immobiliare di Teodoro Mazzaferro, membro di una delle famiglie storiche che gravitano attorno all’orbita dei Piromalli. Mazzaferro è un uomo all’antica che non dice mai “io”. Dice “noi”. E parla coi fatti: 5 milioni di euro per la casa di via Borsi proposti e riproposti nel corso di varie ricognizioni nell’appartamento, vuoto e bloccato dalle liti fra gli eredi. Un sopralluogo si è tenuto a sorpresa il 13 agosto di qualche anno fa con la città deserta. Ma una degli eredi, Maria Ida, si è opposta e la transazione non è andata a buon fine.
Fa niente. Loro sanno aspettare. Se con le buone non passano, ci sono sistemi più diretti, più congeniali ai loro cent’anni di storia. Si è visto con l’omicidio Musco. Una storia di femmine, forse di usura. E, chi sa, domani di droga. Basta cambiare calibro.
8 ottobre 2013